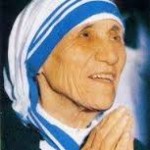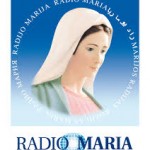L’Anglona fra sardo e còrso durante l’età moderna
 Per quanto riguarda Castelsardo, i primi accenni sulla sua varietà linguistica sono riferiti da Vittorio Angius che scriveva: “Usasi la stessa (lingua) che parlano la massima parte de’ galluresi” 166. Ma non sappiamo, a causa del periodo e della competenza linguistica dell’Angius, quanto questa osservazione corrispondesse all’effettiva realtà da lui osservata a Castelsardo nel periodo immediatamente precedente al 1837.
Per quanto riguarda Castelsardo, i primi accenni sulla sua varietà linguistica sono riferiti da Vittorio Angius che scriveva: “Usasi la stessa (lingua) che parlano la massima parte de’ galluresi” 166. Ma non sappiamo, a causa del periodo e della competenza linguistica dell’Angius, quanto questa osservazione corrispondesse all’effettiva realtà da lui osservata a Castelsardo nel periodo immediatamente precedente al 1837.
Leggi tutto
Commenti disabilitati su Studi storici sui dialetti della Sardegna Settentrionale di Mauro Maxia – Capitolo VIII . Leggi tutto

Enrcio Serpieri
Nato nel 1809 a Rimini da una famiglia di industriali e commercianti, sì iscrisse, a 18 anni, in Medicina a Bologna. Nel 1831 partecipò ai moti rivoluzionari militando nella “Legione Pallade”. Per evitare d’essere coinvolto nella repressione, si rifugiò a Marsiglia, ma espulso dalla Francia, riparò a San Marino, ospite dell’amico patriota Lorenzo Simoncini. Da questa Repubblica continuò a cospirare d’intesa con i patrioti di Rimini, utilizzando la vetreria di famiglia per gli incontri e le riunioni con gli adepti della Giovane Italia.
Nel 1833 il Serpieri osò schernire pubblicamente insultandoli, i volontari papalini che sfilavano, in città, scortati da soldati croati.
Leggi tutto
Commenti disabilitati su Enrico Serpieri di Paolo Amat di San Filippo . Leggi tutto
 Una dì di primmu stiu, cand’eru steddhu, li scoli erani ghjà finiti, andèsi cun babbu a cilcà dui capi vaccini chi, no era la primma ‘olta, c’erani mancati da la sera innanzi. Mi piacìa andà cu iddhu in campagna candu pudìa e no mi parìa ‘eru, libbaru da lu studiu, di pudé fà insembi una beddha caminata a l’aria maseda e pulita. Iscisimi chizzu, ch’era più friscu e vi sarìa vulutu tempu. Lassata la macchina a pocu ghjettu da lu paesi, a lu cumenciu d’una straditta bianca, attraissata da unu riareddhu, bisugnàa sighì a pedi pa una semita in mez’a mureddhi a siccu priculanti e carragghjati, a tratti, da fraschi spaltichinati chi calche unu , pa pudé passà, aìa discarratu.
Una dì di primmu stiu, cand’eru steddhu, li scoli erani ghjà finiti, andèsi cun babbu a cilcà dui capi vaccini chi, no era la primma ‘olta, c’erani mancati da la sera innanzi. Mi piacìa andà cu iddhu in campagna candu pudìa e no mi parìa ‘eru, libbaru da lu studiu, di pudé fà insembi una beddha caminata a l’aria maseda e pulita. Iscisimi chizzu, ch’era più friscu e vi sarìa vulutu tempu. Lassata la macchina a pocu ghjettu da lu paesi, a lu cumenciu d’una straditta bianca, attraissata da unu riareddhu, bisugnàa sighì a pedi pa una semita in mez’a mureddhi a siccu priculanti e carragghjati, a tratti, da fraschi spaltichinati chi calche unu , pa pudé passà, aìa discarratu.
Leggi tutto
Commenti disabilitati su “La fura” di Antonio Meloni & Maria Teresa Inzaina . Leggi tutto
 La cerimonia si è svolta nella sala Angioi che era praticamente gremita. Alla serata, che è stata allietata da alcuni intermezzi musicali, ha partecipato anche il dott. Angelo Mura, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di cui è vice presidente.
La cerimonia si è svolta nella sala Angioi che era praticamente gremita. Alla serata, che è stata allietata da alcuni intermezzi musicali, ha partecipato anche il dott. Angelo Mura, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di cui è vice presidente.
Leggi tutto
Commenti disabilitati su Mauro Maxia: premiato dalla Giunta del Volontariato della Provincia di Sassari . Leggi tutto
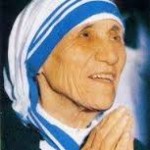
Santa Teresa di Calcutta
DONNA
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.
Però ciò che é importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito e` la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza.
Leggi tutto
Commenti disabilitati su “Donna” di Santa Teresa di Calcutta “Femina” traduz. di Maria Sale . Leggi tutto
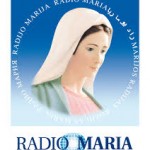 Radio Maria è ormai universalemte conosciuta, nata ad Erba (Como) ha figliato un pò in tutti i continenti quasi 70 figlie che hanno preso il nome della madre, giusto Radio Maria. Per campare queste numerose figlie e altre che si fanno avanti nei paesi poveri occorrono aiuti finanziari periodici o quanto meno una tantum. D’altra parte Radio Maria, oltre ad offrirti la Santa Messa mattutina, il rosario e le lodi, nel corso della giornata offre catechesi da parte di vari esperti, consulenza medica di ogni genere, tavole rotonde di approfondimento su tematiche di attualità sia di giorno che di notte e l’opportunità della preghiera nelle ore del giorno e della notte.
Radio Maria è ormai universalemte conosciuta, nata ad Erba (Como) ha figliato un pò in tutti i continenti quasi 70 figlie che hanno preso il nome della madre, giusto Radio Maria. Per campare queste numerose figlie e altre che si fanno avanti nei paesi poveri occorrono aiuti finanziari periodici o quanto meno una tantum. D’altra parte Radio Maria, oltre ad offrirti la Santa Messa mattutina, il rosario e le lodi, nel corso della giornata offre catechesi da parte di vari esperti, consulenza medica di ogni genere, tavole rotonde di approfondimento su tematiche di attualità sia di giorno che di notte e l’opportunità della preghiera nelle ore del giorno e della notte.
Leggi tutto
Commenti disabilitati su Radio Maria la si ascolta a scrocco, su 100 ascoltatori solo 2 contribuiscono – di A. T. . Leggi tutto
Ecclesiaste 1

Salomone Qoelet
Vanitài di li ‘anitài, dici Qoèlet,
vanitai di li ‘anitài, chi tuttu vanitài è.
A l’omu cosa felma di dugna so’ affannu
candu sutt’a lu soli s’arrineca?.
Anda ghjnirazioni, un’alta ‘eni
ma gali illu so’ ghjru la tarra sempri sta.
E si pesa lu soli e lu soli si cala,
disicendi lu locu da und’ a nascì torra.
Lu ‘entu suffiigghja a mezudì,
e a tramuntana ghjra;
ghjra e poi ‘olta e a li so’ lolghi torra.
Leggi tutto
Commenti disabilitati su Parauli di Qoèlet, di Davide fiddholu, re di Ghjerusalè traduz. di Maria Teresa Inzaina . Leggi tutto
 Bi fuit dae ora, in sos montes de su montiferru, tottu l’ischian, ma nisciunu nde faghiat contu. Fuit pitticcu lanzu e tottu pilosu.
Bi fuit dae ora, in sos montes de su montiferru, tottu l’ischian, ma nisciunu nde faghiat contu. Fuit pitticcu lanzu e tottu pilosu.
Viviad’in d’una grutta, de “sa pattada” una zona de su montferru sutta ‘e badde ulbara inue sun sas antennas de sa televisione.
Cuss’omine antigu fuid inie dae cando s’agattat sa Sardigna.
Curriat cantu unu crabolu, e in sas albures pariad una moninca.
Tottu sos antigos de cussa zona l’han bidu peri sos montes, in cumpagnia de mazzones e polcrabos, ma non de faghian contu.
S’antigu omine ‘e su montiferru da ‘e semper viviat’inie, liberu in mesu sos a animales arestes, e sena tenner fastizzos perunos.
Leggi tutto
Commenti disabilitati su Su chi no ischimus… S’omine antigu de Renzo Rosa . Leggi tutto
 Per quanto riguarda Castelsardo, i primi accenni sulla sua varietà linguistica sono riferiti da Vittorio Angius che scriveva: “Usasi la stessa (lingua) che parlano la massima parte de’ galluresi” 166. Ma non sappiamo, a causa del periodo e della competenza linguistica dell’Angius, quanto questa osservazione corrispondesse all’effettiva realtà da lui osservata a Castelsardo nel periodo immediatamente precedente al 1837.
Per quanto riguarda Castelsardo, i primi accenni sulla sua varietà linguistica sono riferiti da Vittorio Angius che scriveva: “Usasi la stessa (lingua) che parlano la massima parte de’ galluresi” 166. Ma non sappiamo, a causa del periodo e della competenza linguistica dell’Angius, quanto questa osservazione corrispondesse all’effettiva realtà da lui osservata a Castelsardo nel periodo immediatamente precedente al 1837.