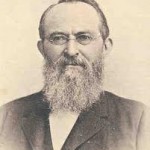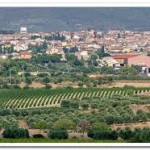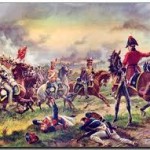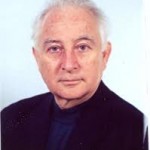Giovanni Piga
Sa die non d’aìat gana Galaneddu de andare chin su babbu a Baddejosso. S’incras bi fit sa prima gara de bullinu, imbentada dae issu, e si depiat allenare bene in su campicheddu isterrau de sa pineta. Sa partia fit de importu mannu, bi depian partezipare peri sos pitzinnos de sos àtteros trighìnzos. Issu, chi fit issiu semper primu in sas isfidas de bichinau, cherìat bìncher peri sa gara manna pro facher bìer a sos àtteros fedales s’abbilidade sua chin sos bullinos de ozastru chi pezzi issu ischiat fàchere e manuzare. Ma chi jocabat bene a bullinu, foras de bichinau suo bi nd’aìat calicun’àtteru, e si cheriat bìncher su pannu bisonzabat chi s’esseret bene ammaniau, e galu mezus depiat irmaestrire a Piloseddu, su catteddu suo, chi li fachiat de cumpanzu in cada gara. Ja est beru chi su bortaidie, impessu ghiraban chin su babbu dae su cunzau, in dommo sua mancu si bortabat, unu cocone in d’una manu, su bullinu in s’àttera, issiat derettu, chin Piloseddu a dainnantis, ocros a su campicheddu. “A ube ses tuccande commo, Galané” li nabat sa mama. “A provare su bullinu” rispondiat, currende, iscurtu, chin d’una bretella pendiolande. Ma commo, s’impinnu de sa gara fit meda mannu e issu cherìat bragare, comente bragabat in sas isfidas de bichinau. Duncas, sa die de sa partìa fit bell’e arribbada, si su babbu che lu piccabat chin issu a Baddejosso, ghirabat istraccu e non si podiat allenare. Peri sas bacàntzias de iscola che fin bell’e accabbadas, si bacàntzias si podìana nàrrer sas suas. Dae mesu làmpadas, cando sas iscolas tancaban, pro tottu su restu de s’istiu, fit rara sa die chi no andabat chin su babbu a Baddejosso, pro contipizare sa binza e irfenare su cunzau, non b’esseret colau focu ch’esseret brusiau sas iffertas nobas chi su babbu, chin contipizu, fit torrande a pesare. S’omine fit iscaddau. Duos annos innantis, unu focu mannu chi si fit pesau in sa cussorja, l’aìat brusiau s’olibare: su trabballu ‘e una bida. Sa binza, peri chin sas crisuras uscradas, mancari atturdia dae s’àlinu buddìu de sas framas, si fit sarbada, chin bona parte ‘e su fruttu. A chie nabat chi su focu si fit pesau solu, pro sa siccanna sichìa, e chie chi fit istau postu dae manu de omine. Pesau solu o postu, fatt’istat chi su focu aìat caminau una die e una notte innantis de resessiren all’istuttare. Sorte ca sa die babbu e fizu fin abbarraos in bidda, si nono non s’ischit si bi si fin pòttios fughire dae cussa traschia de framas. Commo, a bellu a bellu, chin su carinnu ‘e sos beranos, cussa ferta ‘e sa natura si fit torrande a crusiare. Sos mutzos de sas olibas aìan bocau frogas nobas, s’olibare fit torràndesi a téssere. Su babbu de Galaneddu, chi trabballabat istajonale in d’unu cantiere de sa Forestale, sos meses chi non li toccabat s’impreu, si contipizabat sa binza e su cunzau, ube s’aìat parau pacas puddas e unos cantos mojos. Galaneddu, galu a fàcher nob’annos, andabat de bonu coro a su podére. Fit pitzinnu abbistu e bene protzediu in sa paràgula e in tottu su chi si poniat a fàchere: in sas cosas de iscola e in sos jocos, de sos cales medas si los imbentabat issettotu. De sos jocos, su prus chi l’aggradiat fit su bullinu. Non b’haiat cumpanzu, fedale o prus mannu, chi resessiat a li colare a dainnantis. Su bullinu li trampabat peri sa gana. Non l’incantabat àtteru: si l’aìan apiu dassau fit istau abbarrau die e notte jocande e fachende bullinos. Nd’aìat unu pore, pintaos a cada colore e cadaunu chin sas bìnchidas iscrittas a tinta birde, remonios a galabera in d-una ispétzia ‘e piattera antica adattada a s’impreu dae su jaju, mastru ‘e linna a s’antica.
Leggi tutto
 Ci sono giorni
Ci sono giorni